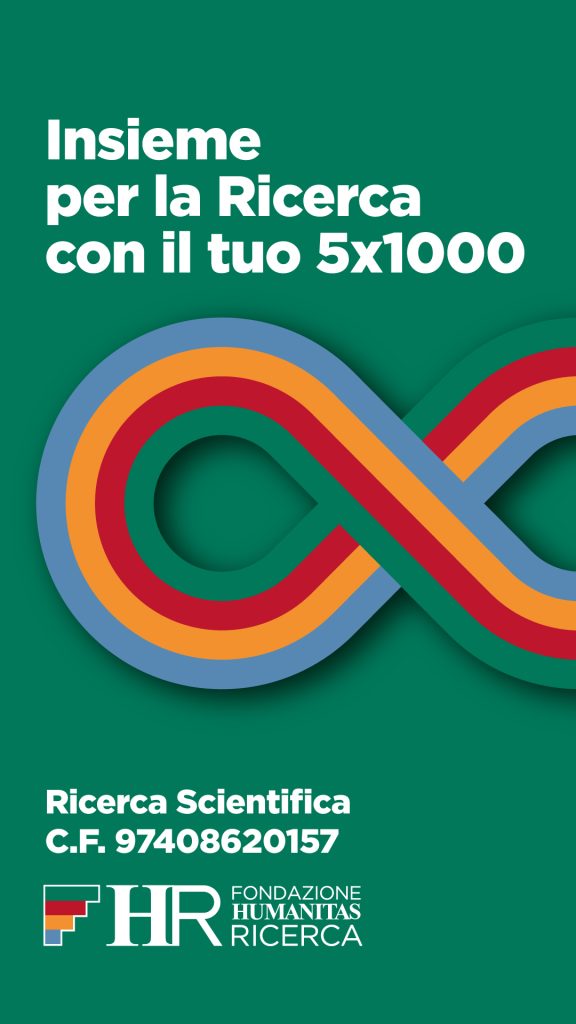Che cosa è il mal di gola?
Il mal di gola è un’irritazione alla gola che provoca dolore, in particolare quando si deglutisce.
A quali altri sintomi si può accompagnare il mal di gola?
In base alla sua causa scatenante, al mal di gola si possono associare altri sintomi come starnuti, brividi, febbre, tosse, gonfiori dell’epiglottide.
Quali sono le cause del mal di gola?
Solitamente il mal di gola viene provocato da infezioni virali o da una particolare secchezza dell’aria o anche da irritazioni per sostanze chimiche che sono distribuite nell’aria.
Questa tipologia di disturbo può anche essere causato da alcune patologie, tra le quali si possono elencare: raffreddore, reflusso gastroesofageo, rosolia, scarlattina, tonsillite, toxoplasmosi, tracheite, tumore alla gola, allergie, ascessi, bronchite, difterite, faringite, fibrosi cistica, infezione da streptococco, influenza, laringite, mononucleosi, morbillo, otite, pertosse, poliomielite, tumore alla laringe, tumore alla lingua, varicella.
Quali sono i rimedi contro il mal di gola?
Qualora abbia origine virale, il mal di gola tende a risolversi in una settimana circa e può essere contenuto anche tramite rimedi naturali come caramelle alle erbe e tisane. Qualora sia causato da infezioni batteriche sarà necessario assumere degli antibiotici, ovviamente dietro prescrizione medica.
Mal di gola, quando rivolgersi al proprio medico?
Qualora il problema si accompagni a difficoltà respiratorie (dispnea), a difficoltà ad aprire la bocca e a deglutire per un intervallo temporale superiore a una settimana; con tonsille grosse o con placche, presenza di sangue nella saliva o nel catarro, sfoghi cutanei, mal d’orecchi (otalgia), ingrossamento dei linfonodi del collo sarà consigliabile rivolgersi al proprio medico.
Area medica di riferimento per il mal di gola
In Humanitas Castelli Bergamo l’area medica cui fare riferimento per il mal di gola è l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria.